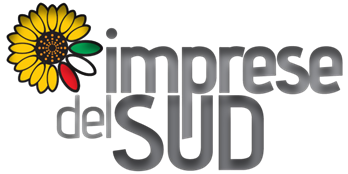Un lavoratore si rivolge a un collega con accuse infondate? A risponderne può essere il datore di lavoro con l’accusa di mobbing. Lo ha sostenuto la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 27913 del 4 dicembre 2020 ha condannato una società a rimborsare una dipendente per un danno subito da condotte vessatorie di altri colleghi.
Ma perché paga l’azienda? Per non aver garantito alla lavoratrice la serenità nel lavoro, e non essere intervenuta a cospetto di maldicenze che avevano un intento persecutorio esplicito all’interno di un ambiente ostile. Il capo ufficio, va sottolineato, nel caso specifico non ha riservato alla collega offese e maldicenze, ma non ha garantito la tenuta di un ambiente di lavoro sereno, che in questo caso esclude l’azienda dal pagamento di danni morali nell’ambito del concetto di sicurezza sul lavoro.
Sicurezza sul lavoro che non è solo fisica ma anche mentale e morale. E che quindi può coinvolgere anche le stanze di un ufficio, e mansioni prive di pericoli fisici.
Gli obblighi di tutela della sicurezza sono previsti dall’art. 2087 del Codice Civile, rispetto al quale i giudici cassazionisti hanno chiarito le responsabilità di un datore non solo dirette ma anche come garante dei suoi dipendenti rispetto a quanto accade nell’ambiente e negli orari di lavoro.
Esiste poi un principio di fondo riconosciuto dalla Costituzione che vede l’attività produttiva subordinata alla utilità sociale: questa però va intesa non solo come mero benessere economico e materiale, sia pure generalizzato alla collettività, quanto, e soprattutto, come realizzazione di un pieno e libero sviluppo della persona umana e dei connessi valori di sicurezza, di libertà e dignità.
Nella fattispecie, la dipendente aveva dichiarato la propria inabilità dal lavoro per tre mesi, e per questo motivo era stata licenziata. Oltre al danno, quindi, la beffa. Ma almeno anche una ricompensa di seimila euro per danni morali.